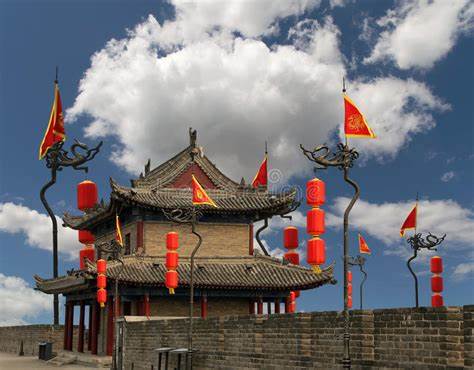Cominciamo dal pensiero di Napoleone: “Quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà”…
Effettivamente si tratta di una percezione diffusa in Europa, ancora oggi. Tuttavia non riflette la realtà, ma una percezione, appunto, tipica dell’”orientalismo” europeo. Più che di “risveglio” della Cina si deve cercare di capire, secondo me, il lungo processo riformatore della Cina, un processo iniziato qualche decennio prima della “profezia” di Napoleone e mai interrottosi fino ad oggi. Inoltre, potrà sorprendere scoprire che la Cina era un paese capitalistico già nel XVIII secolo e che la sua rivoluzione industriale seguiva paradigmi diversi da quelli europei. Insomma, ci sono diverse concezioni ed esperienze di capitalismo su questo nostro pianeta. Nella lunga storia del capitalismo, diciamo dal XV secolo, la Cina non ha avuto bisogno di “copiare” dagli europei, che peraltro considerava industrialmente arretrati, ma fu il Giappone che sin dagli inizi ha sviluppato la tecnica del “reverse engineering”. Per averne conferma, basta visitare il Museo d’Arte Antica – l’Armeria – al Castello sforzesco di Milano. La polvere da sparo fu derivata dagli europei che nel XIV secolo importarono la “polvere nera” dalla Cina, dove si utilizzava per i fuochi d’artificio. Nacquero le armi da fuoco europee, l’archibugio, che nel XVI secolo arrivò in Giappone: “Un giorno, una giunca cinese diretta ad Okinawa è costretta ad ormeggiare a Tanegashima, all’estremità settentrionale dell’arcipelago delle Ryukyu, per sfuggire ad una violenta tempesta. A bordo dell’imbarcazione vi è una compagnia di avventurieri portoghesi e tra il loro equipaggiamento fanno bella mostra di sé anche alcuni archibugi. Il signore dell’isola, Tanegashima Tokitaka, intuisce immediatamente le potenzialità di queste nuove armi e, non si sa se con le buone o con le cattive, riesce ad ottenerne alcuni esemplari che invia immediatamente al suo miglior fabbro, con l’intenzione di replicarle per equipaggiare il proprio esercito”[1]. Il “reverse engineering” giapponese ha avuto inizio allora e negli anni ’80 del Novecento fu causa di notevoli tensioni commerciali con l’Occidente.
Dunque, adesso andiamo in Cina.
La celebre profezia, pronunciata da Napoleone nel 1816 e poi ripresa da Lenin poco prima di morire, riflette una visione tipica dell’eurocentrismo che a Parigi e Londra, ma anche a Berlino e Mosca, è divenuta conosciuta come “orientalismo”. Come ha scritto Edward Said nella sua magnifica opera ‘Orientalismo” (1978) quel pensiero si basava sulla falsificazione della storia che – contraddicendo, o ignorando, il grande contributo di Adam Smith “La ricchezza delle nazioni” (1776) – sviluppò un “concetto critico” per definire “l’Occidente” attraverso “una visione sprezzante che descriveva l’Est, cioè l’Oriente, come arretrato e/o da civilizzare e modernizzare”. Quell’insieme chiamato “l’Oriente” includeva indistintamente le società dell’Asia, del Nord Africa e del Medio Oriente. Una visione, l’Orientalismo, servile verso il potere che l’aveva generata e tipica espressione di una cultura imperialistica (e coloniale). L’Orientalismo volutamente ignorava che l’Europa era arrivata in ritardo nello sviluppo della ricchezza delle nazioni. Infatti, Smith scriveva nel 1776 che “la Cina è un paese molto più ricco di qualsiasi altro in Europa” (per Smith la “ricchezza” era accumulazione di capitale da parte dello Stato-nazione). La rivoluzione industriale europea che seguì – cioè la grande efficienza del mercato dei prodotti e dei fattori di produzione – ha propulso l’Europa a sviluppare una supremazia mondiale che i britannici imposero proprio alla Cina con le guerre dell’Oppio (1839-1860). E’ probabile che Napoleone, pur sempre appartenente ad una minoranza periferica rispetto al “centro”, avesse una visione più realista, in qualche modo più aderente al pensiero di Smith, per cui pronunciò quelle parole.
Lenin, riallacciandosi all’analisi di Marx sul “conflitto degli estremi” capitalistici (1853), memore che la guerra contro l’oppressore russo aveva permesso al Giappone uno sviluppo nazionale indipendente (1905) e che questa indipendenza politica ne aveva permesso lo sviluppo capitalistico, più che una profezia aveva tracciato un’analisi coerente dell’Oriente (Giappone, Cina e India). In più scritti, tra il 1908 e il 1923, Lenin individuava in Asia una delle forze motrici della rivoluzione internazionale. Questa sua convinzione si basava sulla considerazione che il capitalismo asiatico avrebbe spinto le classi subalterne alla ribellione (lotta di classe). Tuttavia, benché promotore della rivoluzione internazionale, Lenin restava figlio della cultura imperiale russo-europea e di un certo orientalismo che gli impedì di vedere “l’autonomia culturale asiatica” nella quale si sarebbero sviluppate ribellioni ma non necessariamente internazionaliste (nel senso bolscevico). Fenomeno rivoluzionario che non è avvenuto in Giappone e in India ma solo in Cina con Mao che, convertitosi al marxismo, esportò un particolare tipo di rivoluzione, quella maoista che, a dispetto delle aspettative di Lenin, ha avuto un impatto culturale ben maggiore nelle gioventù europee e americane che si ribellavano all’imperialismo (si pensi all’impatto culturale del maoismo in Indocina, in Africa e nei movimenti studenteschi del ’68).
Dopo il 1905, il Giappone, come sappiamo, raggiunse presto una maturità capitalistica – quantitativa (concentrazione capitalistica, eccedenza di capitali, esportazione di capitali) e qualitativa (capitalismo monopolistico, imperialismo) – che caratterizzò la sua tendenza militare talmente pronunciata da essere sconfitto solo nel ’45 con l’uso delle bombe nucleari americane.
In Cina, “influenze europee” e “giapponesi” avevano portato a superare il “movimento rivoluzionario anti medievale cinese” adottando gli stessi principi del “populismo russo” (emancipazione delle masse contadine, fine dell’autocrazia zarista, e creazione di una società socialista). Lenin definì “reazionario” il populismo russo che, come quello cinese, era attratto nella corrente della civiltà mondiale capitalistica.
In seguito al fallimento del riformismo e dell’universalismo ispirati dai “testi moderni”, la società cinese era radicalizzata in chiave risolutamente rivoluzionaria e nazionalistica. Pur in declinazioni diverse, la società cinese, nel suo insieme, vedeva come unica via d’uscita per la Cina di “disfarsi dei valori culturali fondati sulla sacralità di Confucio e dei Classici, facendola finita con l’ordine cosmologico-politico tradizionale”. Su queste basi nacque nel 1911 la Repubblica di Cina. Un processo di “risveglio” nazionale, antesignano del contemporaneo movimento woke americano, che oggi continua nel risorgimento (“ringiovanimento”) voluto da Xi.
Sulla “rivoluzione democratica” del 1912, il presidente della Repubblica di Cina Sun Yat-sen (fondatore del partito nazionalista Guomindang) scrisse: “La Cina è alla vigilia di un gigantesco sviluppo industriale” (cioè capitalistico); “in Cina il commercio” (cioè il capitalismo) “raggiungerà proporzioni enormi, fra cinquant’anni vi saranno da noi molte Shanghai, e cioè molti centri di ricchezza capitalistica e di indigenza e miseria proletaria, con milioni di abitanti”. Lenin notò l’ironia della storia del populismo cinese che “in nome della lotta contro il capitalismo” nazionalizzò le terre ma applicò “all’agricoltura un programma agrario la cui piena attuazione importerebbe il più rapido sviluppo del capitalismo nell’agricoltura”.
Nella guerra civile cinese, all’interno di uno stesso quadro di populismo cinese capitalistico, soprattutto dopo la miserevole sconfitta della ribellione dei Boxer (1899) – ultimo tentativo di riscossa tradizionalista e antioccidentale sostenuta dalla vedova Ci Xi della dinastia Manciù – si contrapponevano le forze del sud (proletariato urbano delle coste) che saranno guidate dal nazionalista ultra reazionario Chiang Kai‐shek – ispiratosi alla precedente rivolta di Taiping “in nome del culto del Dio dall’alto”, un settarismo sincretico di derivazione cristiana e buddista compatibile con il pensiero occidentale – e quelle del centro (masse di contadini spossessati) che saranno guidate da Mao Tse-tung, convertitosi al marxismo ma erede culturale di Wang Fuzhi, simbolo della resistenza al dispotismo Manciù e iniziatore della prima esperienza su larga scala di organizzazione sociale su base riformista. Paradossalmente la rivoluzione nazionalista di Chiang Kai‐shek aveva elementi più simili a quella bolscevica (proletariato urbano guidato dalle élite per l’assalto ai palazzi del potere) mentre Mao Tse-tung conservò solo il concetto leninista di “avanguardia” rivoluzionaria ma, cosciente che non c’era più alcun “Palazzo d’Inverno” da assaltare, teorizzò una rivoluzione sistemica (circolare) tra avanguardie e masse sintetizzata nel concetto “dalle masse per le masse” (concetto democratico mutuato dalla tradizione cinese). I contadini armati e organizzati da Mao – concetto alla base dell’attuale esercito cinese (PLA) – avevano motivazione e necessità di cambiare strutturalmente il sistema cinese (riforma agraria, che invece Chiang Kai‐shek ignorava) attraverso riforme progressive, inclusive e continue che nel 1949 portarono alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
L’adesione di Mao Tse-tung all’ideologia marxista culminò nella presa del potere da parte dei comunisti (1949) e con la fuga dei sostenitori del Guomindang a Taiwan, Hong Kong, Tokio, e Stati Uniti. Tuttavia, la presa del potere dei comunisti di Mao si configura, scrive Anne Cheng nel suo “Storia del pensiero cinese”, come “la decisione di mutuare, tale e quale, tutto un sistema dall’Occidente”. Programma che fu seguito da Mao Tse-tung fino alla rivoluzione culturale (1966-1976) che mise in atto il progetto di fare “tabula rasa” con la tradizione. Una “teoria della cancellazione” antesignana del contemporaneo cancel culture americano. Le ferite di quel periodo sono tuttora presenti in Cina.
La così detta “sinizzazione” del marxismo di Mao – idea rifiutata dai neo-confuciani cinesi rifugiatisi a Hong Kong, Taiwan e negli Stati Uniti – sarebbe una “particolarità” tipica della rivoluzione “socialista” cinese, un tentativo di sintesi tra rivoluzione e nazionalismo (da cui, negli anni ‘80 è derivato il concetto “un paese, due sistemi”, progressivamente abbandonato dopo il 2016). Lenin aveva già identificato come “opportunismo” le presunte “condizioni particolari” o “particolarità nazionali” che mascherano le tendenze riformiste, la collaborazione di classe, il contrabbando del capitalismo di Stato con l’etichetta socialista. Una “particolarità” che con la “via cinese al socialismo” di Deng Xiaoping (1978) è divenuta definitivamente esplicita, e che dal 2013, sotto la guida del presidente Xi Jinping, grazie ai vantaggi economici acquisiti dopo l’ammissione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio (2001) – il surplus commerciale – ha assunto le caratteristiche di quell’imperialismo – “capitale divenuto internazionale e monopolistico” – che fu già della Francia, dell’Inghilterra, della Germania e della Russia. Trionfo del capitalismo asiatico, ma resta aperto il dilemma di che fare della tradizione cinese, visto che se modernizzazione significa occidentalizzazione ciò si tradurrebbe in un’alienazione reale e nella perdita dell’identità culturale cinese. Di questo diremo più avanti.
In termini smithiani, la “via cinese al socialismo” ha portato alla divergenza, al disequilibrio globale tra la carenza di forza lavoro e l’eccesso di capitale. In altre parole, in poco più di trent’anni la Cina ha sia potuto fornire una vasta forza lavoro sia accumulare un importante surplus di capitale, particolarmente in varie denominazioni finanziarie del dollaro americano (T-Bonds e azioni) e in lingotti d’oro. Attraverso il surplus generato dalla politica commerciale – resosi possibile grazie alle difficoltà strutturali del capitalismo occidentale – la Cina ha potuto assicurarsi contratti pluriennali di fornitura di gran quantità di materie prime e dopo la guerra russa in Ucraina (2022) di una quota significativa di energia russa a basso costo. Vantaggi comparativi eccezionali. Non si può negare – lo riconosce anche la Banca Mondiale – che nello stesso tempo la leadership della via cinese al socialismo ha saputo “estrarre dalla povertà” circa 800 milioni di persone e che, oltre a qualche centinaio di multi-miliardari, circa 300 milioni di cinesi sono oggi benestanti o “classe media”. Un indubbio successo economico e sociale del capitalismo di Stato e della “via cinese al socialismo”, realizzato in una trentina d’anni. Nello stesso periodo di tempo, invece, la classe media americana ed europea, grazie alle teorie neoliberiste, si è impoverita, ha perso potere d’acquisto e servizi di welfare, mentre la ricchezza si è concentrata in modo spropositato in un manipolo di individui.
Oggi, anche il neoliberalismo – quel movimento capitalistico occidentale nato negli ’20 con l’ambizione di creare un nuovo ordine mondiale fondato sulle regole – è in crisi. Il fallimento delle istituzioni mondiali sovranazionali create dal neoliberalismo (FMI, ONU, OMC) si è realizzato nel momento del suo massimo successo, dopo il 1989. Come scrive David Singh Grewal nel numero 4/2023 di Limes, l’ideale neoliberale iniziale è stato fagocitato dal neoliberismo – la dottrina estrema del libero mercato che ha generato la globalizzazione degli anni Novanta – per cui “un mondo pacifico e organizzato attraverso un sistema globalizzato sembra sempre più assurdo e pericoloso”. All’ideale neoliberale di superamento degli Stati (e dei nazionalismi) in un sistema mondiale di cooperazione economica, oggi si contrappone il ritorno in forza degli Stati e di nuovi imperialismi. Punto di svolta è stata la fallimentare irruzione americana in Iraq (2003). Dopo di allora, alla concorrenza del mercato si sta sostituendo la forza dei cannoni.
Oggi, l’imperialismo cinese si scontra con quello degli Stati Uniti (gli imperialismi europei si suicidarono nel ’14). Sul piano commerciale globale le due potenze imperialistiche si equivalgono, con un vantaggio attuale cinese che sarà decrescente per ragioni demografiche. Quindi, la contesa si è spostata sull’innovazione tecnologica, con gli Stati Uniti che hanno imposto sanzioni decise unilateralmente in base a presunte violazioni cinesi del sistema (americano) di regole (international rule of law). E’ indubbio che finora, ma non lo sarà per sempre, la “potenza della sovranità normativa” americana (e al seguito europea) è più efficace ed effettiva rispetto a quella cinese.
Seppur con narrazioni e sintattiche diverse, all’apparenza opposte, la Cina e gli Stati Uniti praticano entrambe “l’esportazione di capitale e la divisione del mondo tra potenze “progredite” e “civilizzate” da una parte e coloniali dall’altra”. Tuttavia, va subito segnalata una differenza fondamentale: secondo il Washington Consensus gli americani esportano unilateralmente un unico modello finanziario che centralizza verticalmente i profitti sull’asse Sud-Nord generando la subordinazione economica e politica; secondo il Beijing Consensus si sviluppa una direzione differente – la versione economica e sociale di Bandung – che predilige la “localizzazione” (adattamento alle diversità e bisogni di ciascun territorio) e il “multilateralismo” (riconoscimento dell’importanza della cooperazione interstatale nella costruzione di un nuovo ordine globale fondato sull’interdipendenza economica ma rispettoso delle differenze politiche e culturali). Come ha scritto Joshua Cooper Ramo nel suo “The Beijing Consensus: notes on the new physics of Chinese power”, “la Cina sta conducendo la sovversione dell’ordine gerarchico globale della ricchezza” attraverso “un percorso che non porta solo allo sviluppo delle altre nazioni nel mondo ma anche alla loro partecipazione in un ordine internazionale che permette loro di essere effettivamente indipendenti e di proteggere il loro stile di vita (way of life) e le proprie scelte politiche”. Sul piano geopolitico e militare la Cina non mostra una strategia aggressiva mentre gli Stati Uniti (con i riluttanti europei al seguito) vogliono applicare alla Cina le condizioni di “contenimento” spaziale, soprattutto marittimo, che caratterizzarono la Guerra Fredda. La crisi di Taiwan è davanti ai nostri occhi!
La strategia geopolitica americana nei confronti del resto del mondo, e della Cina, resta ancorata a tre visioni: la prima è quella del “terzo vince” già praticata nella prima metà del XX secolo in Europa quando gli Stati Uniti finanziavano e approvvigionavano gli Stati in guerra tra loro; la seconda elaborata da Kissinger prevede di cooptare la Cina in un riformato ordine mondiale incentrato sugli Stati Uniti per preservare il dominio del Nord nel mondo; la terza elaborata da Robert Kaplan è una riedizione della Guerra Fredda incentrata sull’Asia sotto la guida americana di una coalizione che a fronte di qualche concessione sarebbe sostenuta da paesi del Sud del mondo. Ognuna di queste strategie, o la loro combinazione, rischiano di sovrastimare il potere degli Stati Uniti non tenendo conto dell’indebolimento del sistema finanziario americano ed europeo. Oltre ad un possibile rischio di olocausto nucleare, i segnali di riorientamento dei surplus di capitale al di fuori degli Stati Uniti e dell’area dollaro/euro dovrebbero far ponderare la possibilità di rischio depressione e di crisi finanziaria che, come avvenne nel 1997-98, inevitabilmente comporta il “rimpatrio degli asset” ai giusti proprietari. Le mosse della Cina, dell’India, dell’Arabia Saudita e dell’Iran dovrebbero far riflettere.
Per concludere, non credo affatto che il mondo tremi a causa del “risveglio” della Cina. Invece, è arrivato il momento per l’Occidente di capire che è necessario abbandonare il logocentrismo del suo retaggio greco, e che la Cina dimostri di riuscire a pensare il mondo oltre l’universalismo. Questo permetterebbe un vero dialogo fra le interrogazioni radicali dell’uno e l’originale concezione dell’altra. L’assenza dei paesi europei è tristemente evidente e, a mio parere, non recuperabile.
L’Occidente mai sazio…. ha svegliato la Cina, e con la sufficienza e arroganza che ci è propria (siamo quelli che le inflissero non poche umiliazioni) cosa pensavamo? Che sarebbero sempre e solo rimasti la nostra “fabbrica”. L’Occidente sempre tronfio e pieno di sé, si era scordato che la Cina, Regno o Fiore di mezzo che dir si voglia, è una Cultura millenaria e allora come non pensare al dopo?
Non sono convinto che “la storia millenaria”, o il richiamo alle “tradizioni”, siano la ragione per cui la Cina ha recuperato lo svantaggio impostole dalle “umiliazioni” del XIX secolo. In una tale affermazione sento profumo di orientalismo. Come ha scritto Anne Cheng nel suo magnifico “Storia del pensiero cinese”, le riforme, già in epoca imperiale, intorno agli anni Trenta del XIX secolo, guidate da Zhuang Cunyu, pur riferendosi agli antichi testi confuciani spostavano l’attenzione dal “riferimento all’antico” alla “riforma del presente”, senza rimuginare il passato ma “volgendosi all’anticipazione del futuro”. Una “riflessione sull’organizzazione del mondo attuale” che richiedeva il superamento degli “Annali delle Primavere e degli Autunni”, cioè lo stretto legame tra riti e leggi (la “tradizione”). Dopo l’umiliante accordo di Nanchino (1842), Wei Yuan pubblicò il “Saggio illustrato sui paesi d’oltremare” che proponeva di lottare contro i “barbari” con le loro armi e di contrapporli tra loro seguendo il vecchio principio di “domare i barbari tramite i barbari”. Questo è il cuore concettuale del ritorno della Cina sulla scena mondiale manifestatosi dopo il 1911, più visibilmente dopo il 1978 e in modo inequivocabile dopo il 2013 (anno del sorpasso in volume economico commerciale della Cina rispetto agli Stati Uniti).
Un cuore concettuale che è valido ancora oggi. Basti pensare al sapiente uso delle tecnologie digitali, inizialmente sviluppate in Occidente, che la Cina fa per indebolire il suo concorrente e avversario, gli Stati Uniti. Da un recente libro di Giuseppe De Ruvo – “Da Hegel a TikTok. Metafisica e geopolitica del capitalismo digitale” – si evince che la strategia digitale cinese, che esplicitamente consolida in modo organico imprese private e Stato, è incentrata sul fornire strumenti (le App) con algoritmi “tarati” sulle faglie della cultura occidentale, riuscendo così a “stimolare” il nihilismo, l’egocentrismo e il narcisismo degli utenti che liberamente le usano (Lucio Caracciolo lo ha definito il “rincretinimento di massa”). Con una combinazione di intelligenza artificiale e aspetti ludici (volontarismo partecipativo), la Cina riesce indirettamente a “minare” la disponibilità delle coscienze per azioni patriottiche, soprattutto militari, anti cinesi (i recenti dati del Pentagono lo confermano). D’altra parte, anche i giganti tecnologici americani (Big Tech) fanno le stesse cose, con visibili ma opache interdipendenze con gli apparati statali. Nonostante l’enorme capitalizzazione delle Big Tech post 2008 (grandi beneficiarie del quantitative easing), dal 2013 le Big Tech stanno perdendo il vantaggio che avevano acquisito tra gli anni Ottanta e la prima decade del nuovo millennio. Ciò è avvenuto per almeno due fattori: il primo è l’iper-capitalizzazione che ha trasformato quelle imprese da innovative e produttive in agenti finanziari, per cui la loro cultura d’impresa è simile a quella dei fondi di investimento; il secondo dipende dalle restrizioni (e enormi multe) imposte dalle regolamentazioni del settore (data e privacy), di cui l’Unione europea è indubbio campione mondiale. La pandemia Covid-19 nel 2020 ha assestato un duro colpo alle Big Tech, con i noti effetti visibili due anni più tardi (decisa riduzione della valorizzazione, circa il 30%, e pesanti ristrutturazioni seguite da massicci licenziamenti). Invece, in Cina, il piano modernizzatore dello Stato nel quale tutte le attività produttive sono inquadrate (e devono contribuire) ha mantenuto una sua coerenza strategica, un alto livello di attività industriale e soprattutto di innovazione. Questo spiega la reazione americana di contrapposizione alla Cina: fino al 2016, su questioni morali (diritti umani, clima, ecc…) che si sono rivelate inefficaci; fino al 2020, su questioni commerciali, proprietà intellettuale e “rispetto delle regole”; dopo il 2020, su questioni come l’innovazione e le tecnologie del silicio (i chip). In questa “strategia di contrapposizione” alla Cina, gli Stati Uniti esercitano enormi “pressioni” sull’Unione europea per indurla a “integrarsi al regime americano” che deve consolidarne la ricchezza (capitali e dati) per contrastare più efficacemente la Cina. L’Unione europea ha ceduto alle pressioni americane sui capitali e sui dati, ha subito la guerra in Ucraina, ma sulla Cina tenta di modulare la richiesta americana di “separazione” (decoupling) con una vaga ed ambigua strategia di “riduzione dei rischi” (de-risking).
Dopo questo inciso sull’attualità, riprendiamo il discorso iniziato nel paragrafo precedente.
Noi europei non vediamo che i tre secoli di vantaggio comparativo che hanno permesso la nostra “presenza” in Asia non si sono tradotti in una posizione di comando nell’economia globale che è rimasta centrata sull’Asia. Ciò è avvenuto perché, come scrive Giovanni Arrighi nel suo magnifico “Adam Smith in Beijing”, le manifatture europee in Asia rimasero non competitive mentre l’argento americano beneficiò le economie asiatiche ma non quelle europee. La Cina era il vero ultimo beneficiario della ricchezza mondiale (ed oggi la storia si ripete). Mentre l’Occidente mobilizzava “le risorse non umane” (capitale e cannoniere), l’Asia (Giappone e Cina) mobilitavano le “risorse umane” offrendo un livello di “flessibilità” che da noi era ed è inesistente. Flessibilità significa che in Asia si era sviluppato un sistema di capacità interpersonali necessario per la specializzazione del lavoro (gli europei avevano avuto un tale sistema fino all’avvento del capitalismo nel XVII secolo) mantenendo l’occupazione di ogni unità produttiva, spesso un gruppo familiare o una comunità territoriale, pienamente occupata. In India, il processo di “flessibilità” nello sviluppo economico fu impedito, fino al 1947, dal potere coloniale inglese che impose feroci regole di divisione del lavoro che costrinsero l’India ad essere il principale fornitore di specifiche materie prime a basso costo per la “madrepatria”, l’Inghilterra, che le trasformava e commercializzava generando enormi profitti (che finanziarono le sue varie fasi di industrializzazione, la potenza militare e quella finanziaria).
Inoltre, pensare che solo in Europa ci si stata la “rivoluzione industriale” non è corretto. In Europa ci fu “il miracolo della produzione” (efficienza del capitale, specializzazione del lavoro) che favorì la concentrazione della ricchezza. In Asia ci fu “il miracolo della distribuzione” che favorì la diffusione dei benefici dell’industrializzazione e di un’industrializzazione meno energivora. Alla fine del XIX secolo il mondo era diviso in due percorsi diversi all’industrializzazione: in Occidente, alta intensità di capitali e di energia; in Oriente, alta intensità di lavoro e basso consumo energetico. Si deve anche ricordare che in modo empirico, nel XVIII secolo un amministratore dell’epoca Qing anticipò di qualche decennio la teorizzazione di Adam Smith su questioni che, in parole nostre, definiremo di governance dello stato e del mercato, di intervento statale nell’economia e della “mano invisibile” del mercato. Non v’è dubbio che Chen Hongmou, come ha scritto William T. Rowe in “State and Market in mid-Qing economic thought”, preferisse il mercato allo Stato, cioè la libera circolazione dei prodotti per stabilizzare i prezzi invece dell’intervento d’autorità dello Stato. D’altra parte, per un amministratore cinese, immischiarsi con “questioni politiche” non era consigliabile.
Sin dalla seconda metà del XIX secolo, la Cina ha avviato una profonda “modernizzazione”, imparando e importando dall’Occidente concetti a lei estranei. La Cina abbandonò lentamente la tradizionale concezione di “mondo o regno di mezzo” (che si riferiva alla specifica storia dello spazio cinese) sviluppando una sua concezione di “progresso” che era un “confucianesimo orientato verso istanze politiche e riformatrici” (Kang Youwei, 1898) che, affinate in chiave esoterica ed essoterica durante l’esilio a Tokio, diventarono fondative, in chiave rivoluzionaria, sia della Repubblica guidata da Sun Yat-sen sia di quella marxista di Mao. Secondo Kang, il “progresso” nella storia dell’umanità si articola in tre epoche assiali: l’età del disordine (nella quale era immerso), l’età della pace possibile (nella quale si può entrare se si adottano le necessarie riforme), e l’età della pace universale (proiettata in un indefinito futuro).
Per la cultura cinese non fu facile “appropriarsi” dei concetti di “sovranità” oppure di “confine”, la sovranità assoluta e i confini rigidi del modo occidentale. Infatti, la cultura cinese ha dovuto coniare dei nuovi ideogrammi per tradurli (spesso più di un ideogramma per vocabolo occidentale). Il problema, la difficoltà, era integrare concetti nuovi (sovranità, confini, parlamentarismo) in una concezione cosmologica antica (Han) che, infatti, fu definitivamente messa da parte. All’apparenza si potrebbe concludere che la Cina fosse in ritardo o comunque indebolita dalla transizione. Ma non era così.
Nei primi anni del XX secolo, la Cina non dubitava più nel concepirsi come “il mondo”, una reinterpretazione di Tianxia (“tutto sotto il cielo”), concetto di universalismo cinese, che oggi potremmo descrivere come “connettore mondiale”, diverso da quello europeo illuministico che credeva ad una superiorità divinatoria per una missione naturalmente civilizzatrice. Il nuovo Tianxia, nella nuova Cina, non è gerarchico com’era nell’antica epoca imperiale e non contiene semantiche cosmologiche, ma è pienamente secolare, riflette l’appropriazione dei principi di diritto internazionale e riconosce il sistema di “coesistenza di nazioni eguali e sovrane” (lieguo bingli). Non fu un caso, che la Cina sostenne risolutamente la creazione della Società delle Nazioni (si noti che, invece, l’URSS fu ammessa su proposta francese nel ’34 ed espulsa nel ’39 in seguito dell’invasione della Finlandia).
In quegli anni, la Cina era un crocevia di idee provenienti dai vari gruppi della diaspora sparsi nel mondo, dalla Russia e da visitatori e conferenzieri importanti come, ad esempio, John Dewey, Columbia University, che portò i concetti di pragmatismo, Bertrand Russell che affrontò il tema del pacifismo, Margaret Sanger che portò i concetti del femminismo sulla liberazione delle donne e il controllo delle nascite, il grande poeta, drammaturgo e filosofo indiano (bengalese) Rabindranath Tagore che rilanciò la centralità delle culture asiatiche ammonendo circa l’enfasi eccessiva sulla civiltà occidentale, e Albert Einstein.
Del confucianesimo, di cui si fa spesso uso strumentale tanto in Cina quanto in Occidente, rimangono tutt’ora, come punto di riferimento, i “Dialoghi” che ispirano il dibattito per “affermare i valori essenziali dell’esistenza umana”. Poiché Confucio, come ha scritto Tiziana Lippiello nella sua introduzione ai “Dialoghi”, “dedicò la sua vita di maestro all’uomo e alla sua peculiare condizione”, la visione del “sogno” cinese pone tutt’ora al di sopra di tutto “l’uomo, i suoi bisogni e le sue paure, le sue incrollabili certezze e le sue terribili insicurezze”. A questa impostazione cinese fa eco Joseph Stiglitz nel suo “Un’economia per l’uomo” che ha sottolineato come sono i governi degli uomini a rappresentare lo strumento essenziale ai fini della “realizzazione di armonia tra gli uomini e tra uomo e natura”.
Se l’operosa Cina, che risponde alla “logica del formicaio”, dapprima ha colto l’opportunità del capitalismo occidentale sempre alla ricerca del maggior profitto al minimo costo, ha accettato di far da fabbrica, poi, cresciuta ha imparato a fare da sè e ha risposto alla sollecitazione come “imprenditore in proprio” e quindi cooperante ma pure “competitor” e di qui la necessità creazione di espansione delle vie di commercio B&R…proiettarsi verso il fuori per fare crescere e prosperare l’interno.
C’è del vero in questa considerazione, ma andrebbe letta, secondo me, in un’ottica più ampia, ad esempio di politica economica. La prima grande considerazione da fare è che il capitalismo non è un monolite, cioè esistono diverse concezioni ed esperienze del capitalismo. Come abbiamo visto, la Cina era un paese capitalistico di successo già prima dell’Europa e degli Stati Uniti. Più che un percorso lineare, quasi apprendistato e successivo affrancamento, credo che la Cina presenti semplicemente un modello diverso di capitalismo, diverso da quello originariamente europeo ed oggi egemonizzato dagli Stati Uniti.
La prima divergenza tra Cina ed Europa si è manifestata tra la fine del XVIII e i primi anni del XX secolo, il periodo nel quale le potenze europee ascendevano ad egemone mondiale. Due concezioni diverse di rivoluzione industriale. Quella europea usava alta intensità di capitali ed energia, una grande manodopera dell’oltremare colonizzato che forniva le materie prime e una limitata manodopera locale per la trasformazione in via di meccanizzazione. Mentre la manodopera era esclusa dal beneficio dell’industrializzazione, i profitti del processo produttivo e commerciale erano centralizzati ed accumulati in mani prevalentemente private. Quella asiatica, cinese e giapponese, disponeva di enorme manodopera ed usava bassa intensità di capitali e di energia. Il risultato industriale permetteva una relativa accumulazione e la diffusione dei benefici dell’industrializzazione. Poiché la misura delle economie europee era piccola rispetto a quella globale, ma anche rispetto a quella cinese o indiana, era sufficiente una minima variazione nei prezzi e quantità nell’importazione delle materie prime e nell’esportazione del prodotto finito per generare un alto tasso di crescita in Europa, particolarmente in Inghilterra. In questa situazione di mercato globale controllato dalle piccole potenze europee non era possibile per la Cina sostenere una guerra dei prezzi che avrebbe portato al drastico incremento di quelli delle importazioni e al crollo di quelli delle esportazioni, con conseguenze sociali ingestibili. La dinastia Qing ne era consapevole e seguendo la bimillenaria dottrina Guanzi (equilibrio tra importante/superfluo, essenziale/periferico, cioè la stabilità politica prevale sull’economia) evitò scelte pericolose. Due secoli più tardi, Cina e India si trovano nella stessa situazione, non più a causa della piccola Inghilterra ma degli Stati Uniti che assorbono da soli un’enorme quantità di energia e materie prime, oltre a controllare il commercio e la finanza mondiali. Una situazione che chiama la vendetta di tutti i paesi, la maggioranza della popolazione mondiale, che finora sono stati esclusi dagli standard di produzione e di consumo degli Stati Uniti.
Nonostante la nota triade ideale dell’Illuminismo europeo (libertà, eguaglianza, fratellanza), la struttura borghese del capitalismo europeo è rimasta violentemente anti-sociale fino ai primi decenni del XX secolo e in America è stata spietata ancor più a lungo. Il modello di capitalismo cinese, invece, rassomigliava già in epoca Qing, e in modo ben più marcato nelle epoche repubblicane del XX secolo, al modello cooperativo e territoriale tipico dell’Umanesimo e del Rinascimento, reinvestendo sul territorio parte dei profitti, cioè, in qualche modo dando luogo ad una “socializzazione” dei benefici dell’attività economica. Una tradizione che la Repubblica Popolare ha modernizzato, enormemente potenziato e ampliato in modo sistematico nel quadro della tutela e dello sviluppo dell’interesse nazionale cinese. Un marxismo neo-smithiano che ha integrato le lotte di classe nel funzionamento stesso del capitalismo cinese. Un risultato eccezionale ed autoctono che né Marx ed Engels né Thomas Friedman avevano previsto o capito. L’interdipendenza non crea uniformità di sistema, un’internazionalizzazione omogenea, un “mondo piatto”. L’economia del mondo non segue le teorie dell’equilibrio smithiane e poi ricardiane, ma presenta divergenze che derivano da fattori non economici, ma culturali, sociali e finanche spirituali.
Come ha scritto Samir Amin in “China, market socialism and US hegemony”, “dopo il 1949, la rivoluzione ha corretto le iniquità delle riforme Qing trasformando il popolo cinese, per cui oggi le classi popolari hanno fiducia in se stesse e sono libere da atteggiamenti di sottomissione, come dimostrano le centinaia di proteste e manifestazioni, anche violente, che si tengono giornalmente ovunque in Cina” (ad esempio, le proteste sociali nel 1993 erano circa 10.000 e nel 2005 circa 87.000). Risultati inesistenti nel Sud del mondo. Nel Nord del mondo le lotte operaie e i sindacati hanno ottenuto qualche concessione. Tuttavia, sin dagli anni ’20 il capitalismo ha adottato l’austerità come metodo “invisibile” di divisione sociale del lavoro pur tollerando la sussistenza formale del compromesso liberaldemocratico (elezioni e pluripartitismo). Gli effetti dell’austerità si vedono molto bene, storicamente con l’ascesa del fascismo, e più tardi, a partire dagli anni ’80, con la progressiva erosione dei diritti sociali, del welfare e, come avviene nel Regno Unito, adesso, anche con la limitazione delle libertà sindacali.
La seconda divergenza si manifestò in coincidenza con il ritorno dell’ottimismo in Europa dopo la Grande Depressione (1873-1896) che fu causata dalla competizione al ribasso dei prezzi e dal limite già raggiunto dell’espansione commerciale. Un ottimismo che non era dovuto ad un recupero dei profitti della produzione industriale ma allo spostamento del surplus di capitale nei servizi finanziari della City e nell’esplosione del credito per l’industria militare. Fattori che portarono la Belle Époque a chiudersi con la deflagrazione del 1914, e dopo il 1918 all’adozione dell’ideologia dell’austerità che, tranne brevi periodi, caratterizza il capitalismo occidentale fino ad oggi. Mentre crollava il sistema capitalistico mondiale centrato sul Regno Unito, la Cina aveva costruito una sua nuova dimensione di sovranità nazionale repubblicana, un’autonomia politica ed economica che le permise di tornare nella comunità internazionale (1912) e partecipare attivamente alla definizione e allo sviluppo delle regole del nuovo ordine mondiale wilsoniano (1919). Su queste basi, la Cina ha sviluppato tra il 1919 e il 1924 una politica internazionalista marcatamente anti-imperialista, condivisa dai nazionalisti e dai comunisti, sostenendo principi incentrati sulla “reciprocità” (ad esempio, pacta sunt servanda, e rebus sic stantibus, poi codificati solo nel 1969 nella Convenzione di Vienna). Le esperienze repubblicane cinesi non hanno mai abbandonato il fondamento anti-imperialista che, grazie alla sua vasta popolazione e alle grandi possibilità di sviluppo del mercato interno, ha permesso alla Cina di non aderire alle “formule” finanziarie neoliberali e neoliberiste (ad esempio, le privatizzazioni e l’austerità). Inoltre, tranne brevi periodi di eccezionale violenza, il “gradualismo” e il “pragmatismo” hanno caratterizzato la storia cinese da almeno quattro secoli. Diversamente dall’esperienza russa, in Cina la modernizzazione non è avvenuta tramite la distruzione ma piuttosto con l’innalzamento economico e educativo delle classi sociali più marginali (i contadini nel 1949 costituivano quasi il 90% della popolazione). La Cina ha dovuto aspettare fino al 1972 per essere riammessa, per strategia americana (Kissinger/Nixon), tra le potenze mondiali (sostituendo Taiwan nel seggio permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e ricevendo concrete assicurazioni sul rispetto della sua sovranità politica e territoriale – “one China policy”). In un rapporto della Banca Mondiale del 1981 si legge che “nelle passate tre decadi la Cina ha ottenuto risultati ineguagliabili riuscendo ad elevare le classi sociali a basso reddito a livelli di soddisfazione dei bisogni primari che nessun altro paese in via di sviluppo ha potuto raggiungere. Sono tutti occupati, ricevono alimentazione sufficiente e i loro figli sono scolarizzati e comparativamente ben educati, e hanno accesso a servizi per la salute e per il controllo delle nascite”. Un risultato inequivocabile che dal 1981 continua a progredire sulle basi del marxismo-leninismo dell’Armata Rossa degli anni ’20 e che dopo l’invasione giapponese degli anni ’30 ha dato, e dà ancora, i suoi frutti. Insomma, la Cina ha un suo capitalismo sociale e nazionale che include anche gran parte dell’enorme diaspora cinese che investe in Cina perché vede i risultati positivi anche per i familiari che vi risiedono. Un capitalismo piuttosto diverso da quello europeo e americano che offre libertà formali (liberaldemocrazia) e benefici effettivi per pochi. Nonostante tutto, anche il capitalismo di Taiwan somiglia più a quello cinese di Pechino che a quello di Washington.
La terza divergenza si è manifestata con la crisi finanziaria 1997-98 (prima che la Cina entrasse nel OMC, 2001) che ha segnato la biforcazione tra i modelli capitalistici che oggi emerge in tutta la sua evidenza con il Sud globale che rifiuta America ed Europa per aggregarsi con La Cina e i BRICS+. La biforcazione era dovuta all’impossibilità per gli americani e gli europei di continuare a produrre beni e servizi a prezzi inferiori rispetto al resto del mondo. Il surplus del resto del mondo ancora era versato nelle casse americane, finanziando il loro deficit, per essere poi reinvestito, secondo le regole americane, nuovamente nei paesi del Sud del mondo. Quel meccanismo si ruppe. Dal 1998 in poi quote crescenti di surplus bypassavano gli Stati Uniti per essere conservate come riserve o trovare investimenti direttamente in destinazioni del Sud. L’effetto fu di “rilassare o relativizzare l’influenza politico-economica del FMI nel mondo”, scriveva il Wall Street Journal nel 2006. La Cina, che per demografia e output economico e commerciale ha un peso specifico significativo, ha continuato a ridurre gli acquisti di obbligazioni statunitensi (T-Bonds) ridirigendo il suo e il surplus del Sud del mondo verso destinazioni nel Sud del Mondo. E’ utile ricordare che questi processi sono avvenuti con l’assistenza di paesi e istituzioni finanziarie del Nord del mondo. Come sappiamo, anche paesi come l’Arabia Saudita – una volta il bancomat degli Stati Uniti – hanno seguito la Cina in questo processo. Nel 2006, all’inizio della grave crisi del credito e delle banche americane, anche l’India, per bocca del primo ministro Mammohan Singh, alla riunione annuale della Banca di Sviluppo Asiatica chiedeva ai paesi asiatici di ridirigere i propri surplus verso i paesi dell’Asia. E’ a questo punto che l’egemonia americana, ma non il dominio, è finita. Da questo momento è iniziata l’emancipazione concreta del “resto del mondo” dalle grinfie dei paesi del Nord, Stati Uniti ed Europa. Adam Smith non avrebbe nulla da obiettare. La Belt & Road Initiative (BRI) le varie istituzioni finanziarie e di sicurezza, e quelle commerciali, che sono state attuate dal resto del mondo con la Cina non sono la replica dell’espansionismo del mercato capitalistico occidentale, come noi vogliamo credere. Si tratta di una vera e propria alternativa sistemica in atto!
E’ chiaro, quindi, che la globalizzazione anni ’90 (americana) era sbagliata concettualmente perché presupponeva di rimettere la Cina nella catena di valore del capitalismo americano basata sull’austerità. Dopo l’implosione finanziaria del 2006-8 americana (risultato prevedibile delle politiche di austerità combinate con l’eccesso deregolamentato della finanza) la Cina ha cambiato rotta con Xi dal 2013. La Cina ha sviluppato una strategia di globalizzazione autoctona. La risposta americana è stata finanziaria e hanno puntato sull’innovazione tecnologica, ma non è bastato e i loro conti pubblici sono progressivamente peggiorati (lasciando ai privati l’iniziativa). Trump non lo aveva capito. Ma Biden ha cercato di invertire la rotta (enormi masse di trilioni nell’economia – “helicopter money”), ma era troppo tardi. La Cina ha accusato gli americani di “produrre money dal nulla” e quindi falsare la loro stessa regola della concorrenza secondo il rispetto delle regole. Gli americani se ne sono fregati e la Cina ha fatto un “balzo” tecnologico autoctono che gli americani cercano di fermare per via geopolitica (Taiwan) e commerciale (sanzioni) sperando di bloccare l’innovazione cinese (combinazione efficiente di soluzioni digitali e IA). Ecco dove siamo oggi, mentre gli europei sono costretti, ancora, a seguire gli americani in una folle guerra alla Russia e, chissà, domani alla Cina.
L’Europa farebbe bene a svegliarsi dalla mimica americana e riconoscere al più presto la realtà che la circonda. Continuare nella posizione servile e servente degli Stati Uniti si sta già trasformando nel più grande rischio per gli interessi chiave degli europei. Sul Financial Times l’editorialista Wolfgang Münchau ha scritto che “l’economia dell’UE non è costruita per relazioni in stile Guerra Fredda perché è diventata troppo dipendente dalle catene di approvvigionamento globali … La realtà di fondo dell’Europa moderna è che non può facilmente districarsi dal suo rapporto con la Cina”.
[1] https://ilviaggiodiodisseo.wordpress.com/2017/10/04/lintroduzione-delle-armi-da-fuoco-in-giappone/